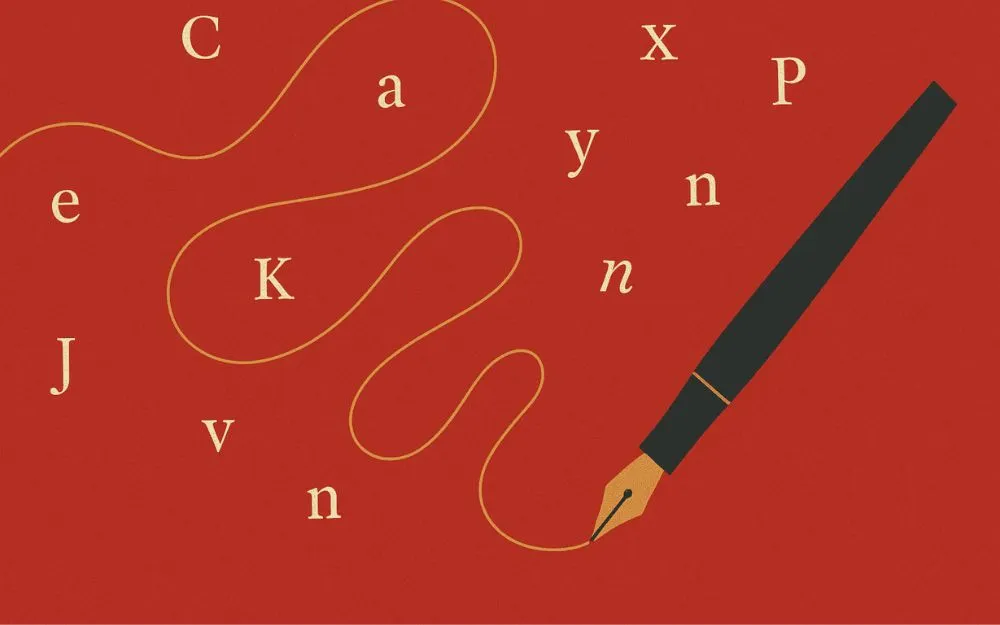In un’epoca dominata dal digitale, Sandro Cappelletto – Critico musicale, Storico della musica, Scrittore, Consulente artistico della Fondazione La Notte della Taranta – ci guida dietro le quinte degli spettacoli dal vivo: tra stagioni affollate, scelte prudenti e una domanda crescente di esperienze autentiche. Un’intervista su cosa voglia dire oggi fare cultura dal vivo, tra tradizione e innovazione, tra esperienze fisiche e digitale.
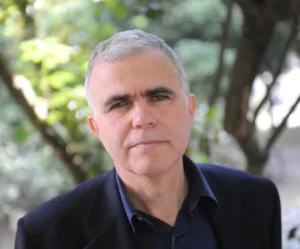
Come descriverebbe oggi lo stato di salute dello spettacolo dal vivo in Italia?
Vivace, con esiti alterni. Le produzioni e le proposte sono numerose, distribuite tra le normali stagioni da autunno a primavera e i tanti festival estivi. L’aspetto numerico, quantitativo, tende a prevalere, a volte, sulla ricerca qualitativa.
In generale si nota – in particolare per le principali istituzioni di spettacolo – una tendenza alla prudenza, nella persuasione di assecondare così il mainstream del gusto del pubblico.
Diminuisce il compenso medio per gli artisti, in particolare i più giovani, a vantaggio dei consistenti e intoccabili cachet riservati ai protagonisti dello star-system.
Che cosa rende unica l’esperienza dal vivo in un’epoca sempre più digitale?
Il fatto che non sia, appunto, digitale. C’è un disperato bisogno di esperienze dal vivo, una sete di “verità” rappresentativa. Si sente sempre più l’esigenza di far migrare l’interprete dalla realtà virtuale a quella fisica, di condividere una sensazione mentre accade, assieme ad altri, superando l’isolamento triste in cui spesso si consumano le esperienze digitali.
Nell’ambito degli spettacoli dal vivo, come si bilancia l’esigenza di innovare con quella di conservare e tramandare?
Questo è il problema più rilevante che devono affrontare le direzioni artistiche più consapevoli. Difendere il repertorio consegnato dalla tradizione, indagarlo ancor meglio per riportare alla luce titoli e autori dimenticati (per la musica, è il caso, clamoroso e internazionale, della cosiddetta barock-renaissance), e nello stesso tempo dare fiducia alla creatività contemporanea.
In questo ambito, assai più coraggiosi sono gli organizzatori degli spettacoli di danza rispetto ai colleghi del teatro e della musica, che tuttavia hanno degli importanti festival dedicati alle nuove creazioni. Occasioni che però è importante non trasformare in ghetti, se si rivolgono solo a nicchie di pubblico.
Che ruolo gioca la multidisciplinarietà nella formazione dei nuovi professionisti dello spettacolo?
Quando parliamo di multidisciplinarietà intesa come conoscenza delle nuove tecniche offerte dal digitale, è certamente necessario acquisire queste competenze: penso in particolare ai registi, agli scenografi e ai musicisti che usano le tecnologie elettroniche per la creazione e la diffusione del suono.
Se intendiamo la multidisciplinarietà come l’incontro tra diversi generi di spettacolo – musica, teatro, danza, aspetti visivi – bisogna ricordare che ad ogni ingrediente aggiunto deve corrispondere una necessità drammaturgica. Non orpelli, dunque, ma sostanza.
Come è nata La notte della Taranta e come è cresciuta fino a questo punto?
È nata per la pressione creativa esercitata, già a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, da alcuni gruppi musicali di ricerca e restituzione del repertorio folklorico salentino. Era forte la percezione del rischio che, con le mutate condizioni sociali ed economiche e con la scomparsa dei testimoni storici, quel patrimonio si sarebbe potuto disperdere. Ma l’impulso decisivo è venuto da scelte di politica culturale che hanno compreso e agevolato l’importanza del progetto.
Difficile era invece prevedere l’esito massiccio di questa operazione e il fatto che La Notte della Taranta sarebbe diventato un marchio internazionale. Evidentemente questa musica tocca corde ancestrali e mai sopite della nostra sensibilità, fisica e mentale. Gestire il fenomeno significa anche difenderlo dalle derive stilistiche che spesso si accompagnano alle manifestazioni di maggior successo, quando diventano significative anche per il loro impatto economico sul territorio in cui operano.
Quali competenze sono necessarie per lavorare nell’organizzazione di Festival ed eventi di questa portata?
È necessario distinguere e coordinare le diverse competenze: artistiche, tecniche, organizzative, manageriali, politiche. Sempre tenendo presente il budget a disposizione per evitare il rischio di crolli economici. Nessuno è in grado di fare tutto da solo. Organizzare lo spettacolo dal vivo significa coordinarsi, dialogare, ascoltare. E, solo infine, decidere.
Lei è docente sia del Master in Management dello spettacolo dal vivo sia di quello in Festival ed eventi culturali di Treccani Accademia: se potesse dare un solo consiglio a chi sceglie di intraprendere uno di questi percorsi, quale sarebbe?
Partecipare in prima persona ad alcuni eventi dal vivo. Diventare invisibili, intrufolarsi in ogni angolo. Ascoltare, vedere, annotare quanto funziona e quanto può essere migliorato. Non prendere posizione fino a quando non si hanno tutte le informazioni. Non essere egolatri. Non credere di essere insostituibili.